Come noto, il “diritto d’autore” si riferisce al coacervo dei diritti spettanti in capo all’autore di un’opera dell’ingegno di carattere creativo (art. 1 L. 22 aprile 1941, n. 633, di seguito anche solo “LDA”).
Il diritto d’autore, o per meglio dire i diritti in cui la tutela delle opere di ingegno si estrinseca, possono essere catalogati in diritti morali e diritti patrimoniali.
I diritti morali, che sono inalienabili e appartengono in perpetuo all’autore, tutelano la personalità e la reputazione dell’autore stesso, la paternità e la gestione dell’opera (ad es. il diritto di pentimento, il diritto di ritirare l’opera dal commercio, o quello di rivendicarne la paternità, il diritto ad opporsi a modifiche e rielaborazioni dell’originale, c.d. diritto all’integrità dell’opera).
I diritti patrimoniali sono, invece, quelli relativi allo sfruttamento economico diretto o indiretto dell’opera e possono costituire oggetto di cessione.
Distinti dal diritto d’autore in senso stretto sono i cosiddetti diritti connessi al diritto d’autore (d’ora in avanti solo “diritti connessi”), che nascono in capo a soggetti diversi dall’autore dell’opera e sono disciplinati agli artt. 72 e ss. della L. 633/1941.
Come è possibile ricavare dalla L. 633/1941, i principali diritti connessi sono per l’appunto:
a) i diritti del produttore di fonogrammi(art. 72 LDA), il quale può autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio e la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi di cui ha curato l’incisione e la realizzazione;
b) i diritti del produttore di opere cinematografiche o audiovisive(art. 78 ter LDA), il quale può autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio e la messa a disposizione del pubblico dell’originale o delle copie delle proprie realizzazioni;
c) i diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva(art. 79 LDA), spettanti a coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva e che hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la ritrasmissione e la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni e trasmissioni;
d) i diritti degli artisti interpreti ed esecutori(art. 80 LDA), ovvero gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico: costoro hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio, la distribuzione delle loro prestazioni artistiche;
e) i diritti relativi alle fotografie(artt. 87 ss. LDA), intese come immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche: spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia;
f) i diritti relativi al ritratto: secondo l’art. 96 LDA, il ritratto (pittorico, scultoreo o fotografico) di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.
Il diritto di sfruttamento economico dell’opera e i diritti connessi risultano di difficile tutela, essendo nella stragrande maggioranza dei casi riferiti ad opere la cui fruizione avviene da parte di una moltitudine di soggetti indistinti o di difficile, se non impossibile, individuazione. Fenomeno quest’ultimo che ha assunto carattere ancora più eclatante per effetto dell’innovazione tecnologica, che ha aggiunto nuove modalità di utilizzo e fruizione delle opere, rendendo praticamente impossibile per un singolo autore controllare che della sua opera non si faccia uso non autorizzato attraverso la radiofonia, la televisione, il satellite, le reti informatiche. D’altra parte, anche per gli stessi fruitori ed utilizzatori dell’opera dell’ingegno non è sempre agevole rintracciare i titolari dei diritti, chiedere autorizzazioni, negoziare il compenso economico e le altre condizioni di sfruttamento.
Per tali ragioni, i titolari dei diritti di autore o dei diritti connessi sono soliti conferire mandato a società di intermediazione (c.d. società di gestione o collecting), che curano la gestione collettiva dei diritti e consentono ai titolari degli stessi di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare. La gestione collettiva dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l’audit degli utilizzatori, il monitoraggio dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
In particolare, il mercato dei diritti connessi e la relativa gestione costituiscono attualmente un settore caratterizzato da forti elementi di criticità, come è possibile evincere dalla Risoluzione approvata dalla Settima Commissione del Senato (Resoconto sommario n. 55 del 2 agosto 2023), nella quale viene riportato che gli artisti interpreti ed esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva, hanno rilevato criticità, soprattutto relativamente:
a) alla mancata attuazione delle norme che impongono agli utilizzatori di fornire i dati necessari per poter stabilire il compenso spettante per legge ad attori, interpreti e altri aventi diritto;
b) all’assenza di provvedimenti sanzionatori previsti per legge in caso di difetto di trasparenza dei dati richiesti;
c) all’insufficiente trasparenza nei dati necessari alla regolazione dei rapporti contrattuali sia da parte degli utilizzatori, sia da parte degli organismi preposti a gestire ed amministrare i diritti connessi per artisti interpreti ed esecutori;
d) alla presenza di tariffe non eque rispetto all’esigenza di remunerare in modo adeguato e proporzionato il compenso spettante per legge agli attori, interpreti ed esecutori ed agli altri aventi diritto;
e) all’esigenza di rendere espliciti i parametri per la definizione della contrattazione della tariffa;
f) all’attuazione dei poteri di vigilanza e di regolamentazione di AGCom, che non hanno trovato concreta applicazione determinando numerose difficoltà interpretative ed applicative delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 177 del 2021; sul punto, si rimarca anche il ritardo nell’adozione del regolamento previsto dal richiamato provvedimento.
Il 6 giugno scorso, è stato istituito presso l’AGCom un Tavolo tecnico con l’indicazione di quattro tematiche principali emerse nel corso della medesima consultazione:
1. la corretta e puntuale identificazione dei mandati affidati agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti;
2. la definizione di standard comuni, condivisi e interoperabili delle informazioni che devono essere scambiate tra le diverse categorie di utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti;
3. i criteri per la ripartizione dei compensi riconducibili ai c.d. apolidi (non iscritti ad alcuna collecting e, dunque, spesso ignari dei loro stessi diritti) tra gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti legittimamente operanti;
4. la definizione di modalità chiare e trasparenti in ordine ai termini e alle modalità di corresponsione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti connessi.
Si confida che attraverso il Tavolo tecnico, ma soprattutto attraverso le battaglie di sistema che alcune delle più virtuose e determinate società di gestione dei diritti connessi stanno conducendo, si giunga ad una completa rivisitazione e reimpostazione delle regole che governano la tutela dei diritti connessi.
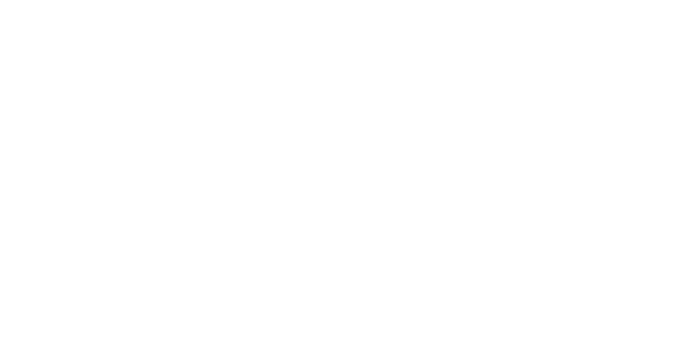
I diritti connessi al diritto d’autore
A cura di Federica Berrino, Associate
Come noto, il “diritto d’autore” si riferisce al coacervo dei diritti spettanti in capo all’autore di un’opera dell’ingegno di carattere creativo (art. 1 L. 22 aprile 1941, n. 633, di seguito anche solo “LDA”).
Il diritto d’autore, o per meglio dire i diritti in cui la tutela delle opere di ingegno si estrinseca, possono essere catalogati in diritti morali e diritti patrimoniali.
I diritti morali, che sono inalienabili e appartengono in perpetuo all’autore, tutelano la personalità e la reputazione dell’autore stesso, la paternità e la gestione dell’opera (ad es. il diritto di pentimento, il diritto di ritirare l’opera dal commercio, o quello di rivendicarne la paternità, il diritto ad opporsi a modifiche e rielaborazioni dell’originale, c.d. diritto all’integrità dell’opera).
I diritti patrimoniali sono, invece, quelli relativi allo sfruttamento economico diretto o indiretto dell’opera e possono costituire oggetto di cessione.
Distinti dal diritto d’autore in senso stretto sono i cosiddetti diritti connessi al diritto d’autore (d’ora in avanti solo “diritti connessi”), che nascono in capo a soggetti diversi dall’autore dell’opera e sono disciplinati agli artt. 72 e ss. della L. 633/1941.
Come è possibile ricavare dalla L. 633/1941, i principali diritti connessi sono per l’appunto:
a) i diritti del produttore di fonogrammi(art. 72 LDA), il quale può autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio e la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi di cui ha curato l’incisione e la realizzazione;
b) i diritti del produttore di opere cinematografiche o audiovisive(art. 78 ter LDA), il quale può autorizzare la riproduzione, la distribuzione, il noleggio e la messa a disposizione del pubblico dell’originale o delle copie delle proprie realizzazioni;
c) i diritti relativi all’emissione radiofonica e televisiva(art. 79 LDA), spettanti a coloro che esercitano l’attività di emissione radiofonica o televisiva e che hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la ritrasmissione e la messa a disposizione del pubblico delle proprie emissioni e trasmissioni;
d) i diritti degli artisti interpreti ed esecutori(art. 80 LDA), ovvero gli attori, i cantanti, i musicisti, i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano o eseguono in qualunque modo opere dell’ingegno, siano esse tutelate o di dominio pubblico: costoro hanno il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio, la distribuzione delle loro prestazioni artistiche;
e) i diritti relativi alle fotografie(artt. 87 ss. LDA), intese come immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche: spetta al fotografo il diritto esclusivo di riproduzione, diffusione e spaccio della fotografia;
f) i diritti relativi al ritratto: secondo l’art. 96 LDA, il ritratto (pittorico, scultoreo o fotografico) di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa.
Il diritto di sfruttamento economico dell’opera e i diritti connessi risultano di difficile tutela, essendo nella stragrande maggioranza dei casi riferiti ad opere la cui fruizione avviene da parte di una moltitudine di soggetti indistinti o di difficile, se non impossibile, individuazione. Fenomeno quest’ultimo che ha assunto carattere ancora più eclatante per effetto dell’innovazione tecnologica, che ha aggiunto nuove modalità di utilizzo e fruizione delle opere, rendendo praticamente impossibile per un singolo autore controllare che della sua opera non si faccia uso non autorizzato attraverso la radiofonia, la televisione, il satellite, le reti informatiche. D’altra parte, anche per gli stessi fruitori ed utilizzatori dell’opera dell’ingegno non è sempre agevole rintracciare i titolari dei diritti, chiedere autorizzazioni, negoziare il compenso economico e le altre condizioni di sfruttamento.
Per tali ragioni, i titolari dei diritti di autore o dei diritti connessi sono soliti conferire mandato a società di intermediazione (c.d. società di gestione o collecting), che curano la gestione collettiva dei diritti e consentono ai titolari degli stessi di essere remunerati per gli usi che non sarebbero in condizione di controllare o fare rispettare. La gestione collettiva dei diritti connessi comprende la concessione di licenze agli utilizzatori, l’audit degli utilizzatori, il monitoraggio dell’utilizzazione dei diritti, l’esecuzione dei diritti connessi, la riscossione dei proventi relativi allo sfruttamento dei diritti e la distribuzione degli importi dovuti ai titolari dei diritti.
In particolare, il mercato dei diritti connessi e la relativa gestione costituiscono attualmente un settore caratterizzato da forti elementi di criticità, come è possibile evincere dalla Risoluzione approvata dalla Settima Commissione del Senato (Resoconto sommario n. 55 del 2 agosto 2023), nella quale viene riportato che gli artisti interpreti ed esecutori, anche tramite gli organismi di gestione collettiva, hanno rilevato criticità, soprattutto relativamente:
a) alla mancata attuazione delle norme che impongono agli utilizzatori di fornire i dati necessari per poter stabilire il compenso spettante per legge ad attori, interpreti e altri aventi diritto;
b) all’assenza di provvedimenti sanzionatori previsti per legge in caso di difetto di trasparenza dei dati richiesti;
c) all’insufficiente trasparenza nei dati necessari alla regolazione dei rapporti contrattuali sia da parte degli utilizzatori, sia da parte degli organismi preposti a gestire ed amministrare i diritti connessi per artisti interpreti ed esecutori;
d) alla presenza di tariffe non eque rispetto all’esigenza di remunerare in modo adeguato e proporzionato il compenso spettante per legge agli attori, interpreti ed esecutori ed agli altri aventi diritto;
e) all’esigenza di rendere espliciti i parametri per la definizione della contrattazione della tariffa;
f) all’attuazione dei poteri di vigilanza e di regolamentazione di AGCom, che non hanno trovato concreta applicazione determinando numerose difficoltà interpretative ed applicative delle novità normative introdotte dal D.Lgs. n. 177 del 2021; sul punto, si rimarca anche il ritardo nell’adozione del regolamento previsto dal richiamato provvedimento.
Il 6 giugno scorso, è stato istituito presso l’AGCom un Tavolo tecnico con l’indicazione di quattro tematiche principali emerse nel corso della medesima consultazione:
1. la corretta e puntuale identificazione dei mandati affidati agli organismi di gestione collettiva e alle entità di gestione indipendenti;
2. la definizione di standard comuni, condivisi e interoperabili delle informazioni che devono essere scambiate tra le diverse categorie di utilizzatori e gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti;
3. i criteri per la ripartizione dei compensi riconducibili ai c.d. apolidi (non iscritti ad alcuna collecting e, dunque, spesso ignari dei loro stessi diritti) tra gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti legittimamente operanti;
4. la definizione di modalità chiare e trasparenti in ordine ai termini e alle modalità di corresponsione dei proventi derivanti dallo sfruttamento dei diritti connessi.
Si confida che attraverso il Tavolo tecnico, ma soprattutto attraverso le battaglie di sistema che alcune delle più virtuose e determinate società di gestione dei diritti connessi stanno conducendo, si giunga ad una completa rivisitazione e reimpostazione delle regole che governano la tutela dei diritti connessi.